In Svizzera il movimento del ’68 prese avvio il 29 giugno. In gioco c’era un centro giovanile autonomo. Uno sguardo alla storia dei centri giovanili mostra che avrebbero dovuto portare nel paese una gioventù socialmente accettabile, mentre in realtà portarono lezioni di democrazia.
Nella calda notte dal 29 al 30 giugno 1968, a Zurigo si scatenò il putiferio: volarono sassi, bottiglie, catene, ricevitori telefonici strappati nelle cabine pubbliche e vasi di fiori. Con un’azione di volantinaggio, nella capitale economica della Svizzera, era stata convocata una manifestazione. La sera la folla era cresciuta fino a superare le mille persone e aveva paralizzato il traffico. La polizia intervenne con manganelli e idranti e la situazione degenerò.
Gli scontri davanti all’ex edificio dei grandi magazzini GlobusLink esterno a Zurigo ancora oggi sono considerati il punto di partenza del movimento del ’68 in Svizzera. La manifestazione era stata indetta per protestare contro il rifiuto del comune di mettere quell’edificio, situato vicino alla stazione centrale di Zurigo, permanentemente a disposizione come centro giovanile autonomo.
Dalla fine degli anni ’60 fino agli anni ’80, l’idea che i centri potessero essere gestiti dai giovani stessi generò una grande forza politica in tutta la Svizzera. A Ginevra, Losanna, Bienne, Basilea, ma anche in piccoli comuni, si combatté per i centri autonomi.
Centri educativi camuffati
Gli esordi del movimento dei centri giovanili furono tuttavia modesti: il primo centro giovanile del paese nacque all’Esposizione nazionale svizzera del 1939 e non fu affatto autonomo. Serviva a “educare i giovani confederati”: c’era una teca in cui gli scout invitavano ad escursioni, sale di musica con strumenti a disposizione di ognuno, un laboratorio per il tempo libero in cui si potevano fare interessanti attività.
L’obiettivo dei primi centri giovanili era di tener lontano i giovani dai “cattivi” intrattenimenti: discoteche, cinema e ristoranti. L’Associazione ferie e tempo libero di Zurigo, nel 1949, riteneva che un centro giovanile dovesse “creare sane strutture educative e di intrattenimento, che corrispondessero allo spirito imprenditoriale dei giovani, rafforzassero il loro carattere e consentissero ai genitori di sapere che i loro figli e le loro figlie lì erano in buone mani”.
Lezioni di charme per i rocker
Nel 1959 fu inaugurato a Zurigo il primo luogo d’incontro per i giovani, il Drahtschmidli. Per molti giovani rappresentò comunque un arricchimento: da qui nacquero giornali scolastici, progetti fotografici e amicizie. Fin dall’inizio, tuttavia, i dirigenti adulti cercarono di coinvolgere i cosiddetti “giovani outsider” in una rotta di collisione con la società.
Venivano convocati personalmente dalla polizia “teppisti” – giovani che ascoltavano il rock’n’roll e giocavano a flipper nei bar. Nel centro giovanile si voleva formare il loro carattere e tramite corsi intitolati per esempio “Chic e Charme” si cercava di portare i ragazzi in blue-jeans verso una moda più ragionevole. Il centro giovanile era di fatto un’istituzione educativa mascherata da struttura per il tempo libero.
Parte dei giovani, tuttavia, richiedevano luoghi che potessero gestire da soli, senza supervisione, e che offrissero più spazio, ad esempio per concerti. Dopo una lunga lotta, alla fine di ottobre 1970, a Zurigo fu inaugurato il primo centro giovanile autonomo, in un rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale. Le autorità cittadine permisero persino che rimanesse aperto tutta la notte, nel caso in cui più di dieci giovani volessero continuare le discussioni.
Questo portò però presto a regolari pernottamenti nel bunker. L’opinione pubblica denunciò la frequentazione del bunker da parte di minorenni, il consumo di alcol e droghe e il rumore. Inoltre, serpeggiava il timore che vi si mescolassero agitatori di estrema sinistra con uno “spirito orgiastico”. L’odore dello scandalo era nell’aria e il bunker si ritrovò presto ai ferri corti con le autorità. In dicembre era già in procinto di chiudere.
Rapida fine di uno stato libero
Nella notte di San Silvestro 1970-71 i giovani del bunker zurighese dichiararono il centro quale territorio fuori dalla “società capitalista” e dalla Svizzera: diventava Repubblica Autonoma del Bunker. L’obiettivo era una gestione collettiva, con assemblee plenarie in cui si sarebbero adottate decisioni sulle sorti dello Stato.
Nel giro di quattro giorni, oltre duemila giovani si iscrissero al “controllo abitanti” e acquisirono il “passaporto”. Ma dopo una settimana il libero Stato era finito: il 6 gennaio 1971, la polizia circondò l’edificio e l’esperimento del Lindenhofbunker si concluse. Oggi ospita il Museo della polizia della città di Zurigo.
Il sogno del bunker era infranto anche per altre aspettative. Il centro giovanile era diventato rapidamente un punto focale per i giovani che avevano rotto i ponti con le famiglie o con gli istituti in cui si trovavano allora: ragazzi che avevano semplicemente bisogno di qualcuno con cui parlare o che avevano problemi di droga.
L’associazione di pubblica utilità “Speak Out”, anch’essa nata dal movimento del 1968, nel bunker forniva per la prima volta un servizio di consulenza autogestito per i giovani su vasta scala e presto si ritrovò sovraccarica. Nel contesto sperimentale del centro giovanile era apparso chiaramente con quali problemi i giovani dovevano lottare. Quale reazione, l’anno successivo furono fondate le prime istituzioni comunali di consulenza per i giovani.
Il centro superstite
Il fatto che un simile esperimento possa anche avere successo è dimostrato dall’ultimo centro giovanile autonomo: quello a Bienne, nel cantone di Berna, che esiste ancora oggi. Negli anni ’60, dei complessi pop locali erano regolarmente confrontati con una carenza di spazio in città. Nei piccoli ristoranti dove potevano suonare, venivano mandati via quando la musica non era gradita dai clienti abituali. Quanto ai grandi locali solo grandi organizzatori commerciali se li potevano permettere.
Nel luglio 1968, dopo gli scontri davanti all’ex Globus di Zurigo, l’idea di un centro giovanile autonomo si fece largo anche a Bienne. Come sito fu scelta la cupola di un vecchio gasdotto, che stava per essere demolita.
Il timore di disordini come a Zurigo favorì le simpatie delle autorità locali. Tuttavia, si dovette ancora aspettare fino al 1970, nel corso di un sit-in, prima di ricevere l’autorizzazione del Consiglio comunale. Dopo lunghi lavori di costruzione, nel 1975 fu inaugurato il Centro autonomo giovanile (CAJ), che fino ad oggi è rimasto un luogo di attivismo politico e di cultura alternativa.
Scuola di democrazia
Dal profilo giuridico, il CAJ di Bienne è gestito da una normale associazioneLink esterno svizzera con statuti, ma internamente si basa ancora sul “Manifesto CAJ”. La “assemblea degli utenti”, ossia la base democratica, si riunisce ogni martedì sera e discute il programma d’attività.
Il movimento del CAJ è sinonimo di autodeterminazione in tutti gli ambiti. Anche la sfera del divertimento non dovrebbe essere consumo puro, ma dovrebbe essere frutto del lavoro comune. Lì sono state create micro-democrazie temporanee e caotiche, in cui si amministravano autonomamente degli spazi separati. Per molti, il 1968 fu quindi anche una scuola di democratizzazione, nonostante tutti i discorsi sulla rivoluzione.
(Traduzione dal tedesco: Sonia Fenazzi)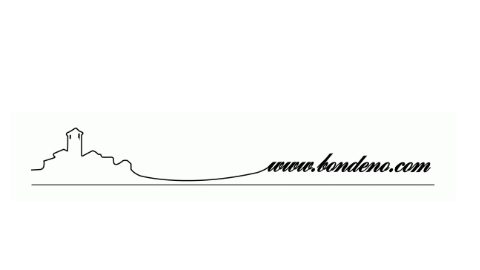






 Stiamo guardando un telefilm, anzi un episodio di quelle serie noiose serie ospedaliere dove la sanità diventa qualcosa di radicalmente diverso da ciò che è in realtà e nelle quali vedremo probabilmente in futuro lo stesso Renzi in crisi da visibilità: c’è una equipe di informatori che dopo i ballottaggi grida “lo stiamo perdendo” e tenta di rianimare un soggetto talmente morto da essere stato sconfitto persino nelle sue cittadelle clientelari: Siena, città del Monte Paschi, valga per tutte. L’accanimento terapeutico di tv e giornali, nel far pensare che un soggetto politico morto come il Pd sia in realtà ancora vivo, seppure malconcio, deriva dal fatto che la razza padrona locale aveva individuato nella creatura di Veltroni l’attore ideale per una fuoriuscita alla chetichella dalla socialdemocrazia e l’approdo verso l’eurismo mercatista mentre ora si ritrova con niente in mano e con una grande incertezza dopo l’esperienza col cialtrone di Rignano.
Stiamo guardando un telefilm, anzi un episodio di quelle serie noiose serie ospedaliere dove la sanità diventa qualcosa di radicalmente diverso da ciò che è in realtà e nelle quali vedremo probabilmente in futuro lo stesso Renzi in crisi da visibilità: c’è una equipe di informatori che dopo i ballottaggi grida “lo stiamo perdendo” e tenta di rianimare un soggetto talmente morto da essere stato sconfitto persino nelle sue cittadelle clientelari: Siena, città del Monte Paschi, valga per tutte. L’accanimento terapeutico di tv e giornali, nel far pensare che un soggetto politico morto come il Pd sia in realtà ancora vivo, seppure malconcio, deriva dal fatto che la razza padrona locale aveva individuato nella creatura di Veltroni l’attore ideale per una fuoriuscita alla chetichella dalla socialdemocrazia e l’approdo verso l’eurismo mercatista mentre ora si ritrova con niente in mano e con una grande incertezza dopo l’esperienza col cialtrone di Rignano.


